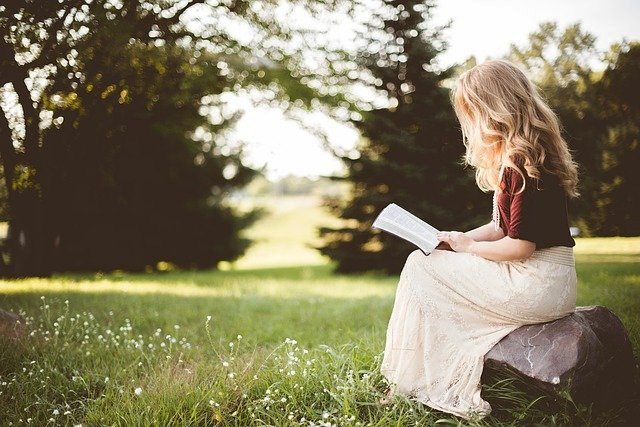Le "leggende" del Maestro Abele Truffa
I Trai Fradà cà Saurjvo Tant Ben ovvero I Tre Fratelli che si Volevano Tanto Bene
Si chiamavano Marcellino, Rocco e Martino.
Erano nati in una cascina fabbricata da antichi parenti sulla collina che molto più tardi sarebbe stata chiamata San Marcellino, perché, raccontavano, in tempi lontani là era stata costruita una chiesetta in onore di quel Santo.
Intorno alla loro casa si estendevano ricchi vigneti, ma la valle era come un grande bosco che occupava parte del territorio di Castagnole e si prolungava nelle campagne di Grana fino alla regione chiamata Baseria. Più che un bosco si sarebbe detta una foresta in cui si alzavano alberi giganteschi e vivevano animali pericolosi come lupi, volpi aggressive, feroci gatti e linci dalla forza straordinaria.
I paesani, che per lavoro erano obbligati a transitare in quelle vicinanze, portavano sempre con sé un fucile ben carico e affilati pugnali.
I tre fratelli vissero a lungo in famiglia sempre lavorando da mattino a sera con tenaci propositi e generosi sforzi e raramente si recavano in paese sia per la distanza, e la cattiva condizione delle strade, sia per il pericolo di dover lottare con i lupi e le volpi. Ma in casa le provviste non mancavano mai poiché erano molto previdenti.
Ma quando i genitori, ormai carichi di anni e di lavoro, passarono all’altra vita, essi pensarono di formarsi una propria famiglia, si divisero con giustizia i beni del padre e si sposarono.
Marcellino rimase nella vecchia casa mentre Rocco e Martino si stabilirono uno sulla collina chiamata Roche e l’altro sulla ben nota altura Martin del Bosco, in case da essi costruite.
Ma siccome il loro affetto non era diminuito lasciando la casa paterna, decisero di dimostrare il loro fraterno amore piantando ciascuno un alto pino sul quale ogni sera issavano un lampione acceso, così essi, dalla propria casa, prima di addormentarsi, contemplavano dalla finestra i pini dei fratelli, illuminati da una bianca luce simile ad una stella: era la loro Buona Notte.
Gli anni passarono laboriosi e sereni mentre la loro casa si popolava di robusti figli. Com’era bello la sera vedere i tre fratelli guardarsi da lontano e chiamarsi per nome.
Anche i paesani, specie nelle serate estive, salivano sul piazzale della Chiesa e guardavano compiacenti i pini illuminati. Durò a lungo la vita dei tre fratelli e fu tanto lunga che essi poterono vedere e accarezzare non solo i nipoti ma anche i pronipoti.
Le nuove generazioni non ebbero il carattere dei familiari poiché non nutrivano l’amore alla terra come i vecchi loro parenti così che, fatti adulti, lasciarono il paese ed emigrarono in America.
Marcellino, Rocco e Martino invece rimasero fedeli alle loro campagne fino agli ultimi giorni della loro esistenza spendendo le ultime energie a maneggiare la zappa e la vanga mentre sui tre pini continuava a brillare la luce della sera.
Ma siccome tutte le cose di quaggiù hanno un fine, anche per i tre fratelli venne l’ultimo giorno, un giorno bellissimo, anzi una sera meravigliosa.
Il caso volle che nella Chiesa del paese si tenesse una solenne funzione serale. Un celebre predicatore commemorava un grande Santo, e si eseguirono canti bellissimi. Quando i fedeli uscirono dal tempio, il loro sguardo si volse spontaneamente verso la campagna e si fissò nella direzione dei tre pini ma con grande loro stupore li videro spenti.
La stessa notte gruppi di paesani si recarono sulle tre colline ma cosa trovarono? I tre fratelli erano spirati mentre si spegneva l’ultima luce del loro saluto serale. Si erano voluto tanto, tanto bene in vita che certamente Dio ha voluto che tutti e tre entrassero insieme in Paradiso.
San Roc ovvero San Rocco
In quel tempo nonno Germano era una figura molto popolare nel Paese; lo s’incontrava volentieri e con tanto piacere si conversava con lui. Aveva un modo di parlare così semplice e insieme così saggio che le ore passate in sua compagnia sembravano minuti.
Bello era anche di aspetto: aveva due occhi profondi come l’azzurro, splendenti di una luce che veniva da un’anima senza macchia, un volto scolpito da un grande artefice. Parlava di cose grandi, di cose che commuovevano, aveva accenti di paterna tenerezza ed era sempre presente nei momenti del dolore e della sventura.
Come i suoi compaesani egli lavorava la terra, conosceva i sacrifici che i campi chiedono all’uomo, le giornate di sudore, le fatiche di lunghe annate. Ma se il quotidiano contatto con la terra aveva piegato la sua persona e dato alle sue mani calli duri come ceppi, l’aria pura, il sole e il profumo delle erbe e dei fiori gli avevano ringiovanito il cuore.
Sotto la calma serenità di questo nostro cielo e nella solenne pace di questi colli fiorenti, egli passava i suoi giorni colmi di opere buone.
Ma il dolore che batte a tutte le porte, arrivò anche alla soglia della sua casa, vi entrò e vi prese abitazione. Egli lo sentì, fece largo al nuovo padrone e con lui divise il pane amaro bagnato di lacrime.
Stette molto nella sua casa il dolore, gli recise i fiori del suo giardino, meno uno: il fiore della Fede, e poi uscì per compiere altre misteriose missioni fra gli uomini.
Germano diventò più curvo, sui suoi capelli scese come un velo di neve e i suoi occhi, per le troppe lacrime versate, s’erano fatti più deboli. Ma la sua parola non mutò suono, ed a quanti lo avvicinavano egli diceva cose che toccavano il cuore e facevano piangere. Il dolore lo aveva santificato.
Scendeva un giorno per la strada denominata Roche, e si dirigeva verso la valle; la campagna in quel luogo era boscosa e non vi andavano che i cacciatori per compiere ricche battute, abbondandovi numerosa selvaggina. Andava per raccogliere un’erba medicinale di eccellenti virtù. Gli si era prodotta una piaga ad un ginocchio, una piaga molto dolorosa ed egli là si recava per chiedere la guarigione alla preziosa pianta. In quell’ora caldissima non c’era nessuno nei campi e la sola nota di vita era il canto degli uccelli.
Nel bosco si sentì triste, ebbe gli occhi umidi di lacrime e in quella solitudine rivide le care immagini dei suoi familiari passati all’eternità. “Non piangete, buon uomo, conosco anch’io le vie del dolore, anzi da anni le percorro, da anni i piedi mi sanguinano, da anni mangio un pane amaro come il vostro”.
Chi parlava così ? Germano cercò con lo sguardo colmo di meraviglia e scoprì ai piedi di un alto cespuglio una figura che gli incusse riverenza e quasi timore. Un uomo dall’aspetto giovanile era là seduto; aveva due occhi da Santo, un volto consumato dalla penitenza, una fronte su cui erano scolpiti pensieri profondi. Anch’egli aveva una piaga ad un ginocchio, un’aperta piaga sanguinante che un docile cane ogni tanto ammorbidiva con movimenti gentili della lingua. Quegli occhi non avevano lacrime ma dicevano di averne sparse tante per i dolori incontrati sul suo lungo cammino. Doveva essere un’anima bella, un eroe della carità.
“Buon uomo”, proseguì , “voi mi assomigliate perché avete accolto il dolore come un amico; non ho avuto altro amico lungo la mia strada, un amico poco cortese, sovente crudele, ma nel mio pianto non mi accorgevo che la via che percorrevo saliva dalla terra al cielo e che quel mio compagno di viaggio prendeva l’aspetto d’un angelo vestito di luce. Coraggio, anima sorella, avete con voi il segreto d’una vita felice che apre i suoi giardini là dove ogni sera fioriscono le stelle. Faccio qui una breve sosta poi riprendo il cammino per le vie del mondo, e sarò là dove mi si chiama, accanto al letto di chi soffre, nelle case dove si piange, dove la speranza sta per morire. Non vi affannate, fratello, a cercare l’erba miracolosa; il mio incontro con voi è per voi un segno di salute”.
Una luce mirabile aveva invaso il bosco, il cespuglio pareva incendiarsi e un profumo di rose, di viole e di gigli si elevava dalle erbe e dai rami. Germano, smarrito, non vedeva che uno splendore e in quel paradiso di colori riconobbe la figura di San Rocco che saliva, saliva benedicendo.
Si parlò a lungo in paese di quel fatto misterioso e, a ricordo, venne eretta una Cappella. Ancora oggi i Granesi guardano con simpatia la bianca Chiesetta e venerano il caro Santo che dalla sua nicchia sorride e benedice.
Chi non conosce la bella collina di San Vito? Essa muove da l’ampia valle del torrente Grana e dolcemente portando con sé fertili campi di grano e granoturco, rigogliose erbe mediche, freschi trifogli e vigneti curati come giardini.
E poiché nella stagione il sole vi batte con tanto ardore, essa innalza vaste ombre di noci, di ciliegi e di olmi. Un tempo non lontano quella di San Vito era la collina più ricca di frutta e molti ricordano l’abbondanza di pesche d’una qualità eccellente e di noci bellissime che fornivano a numerose famiglie un ottimo olio per quasi tutta l’annata.
Ora le vicende degli ultimi anni e specialmente le devastazioni cagionate dalla filossera, hanno mutato il fiorente aspetto della regione, ma i Granesi vogliono bene alla cara collina poiché, molti di essi hanno lassù un pezzo di terra che coltivano con tanto amore.
San Vito con la solitaria sua Cappella ha una interessante leggenda.
In quel tempo, molto lontano, la parte più alta era tutta boscosa e nelle ampie distese di querce, di olmi e di frassini trovavano comodo e sicuro rifugio numerose famiglie di volpi e faine.
La strada carreggiata che ora congiunge il nostro paese con Casorzo non esisteva, ma esisteva un sentiero che guidava attraverso l’oscura boscaglia e conduceva in territorio casorzese.
Erano quelli tempi di aspre lotte sanguinose fra paese e paese, originati da motivi di vendetta o da questioni di interesse, e più di una volta i cacciatori avevano scoperto lungo il sentiero cadaveri di gente assassinata.
Un mattino d’autunno, Vito, giovane ventenne di Grana, si recò a fare legna in quel bosco, suo luogo preferito per le sue buone provviste di combustibile per l’inverno. C’era tanta solitudine fra gli alti alberi ch’egli sentì il bisogno di distrazione e si mise a cantare. La sua voce venne udita al di là del bosco dove un giovane casorzese stava compiendo il medesimo lavoro.
La curiosità di conoscere il bravo cantore spinse l’altro ad attraversare la boscaglia e così i due giovani ad un certo punto si trovarono di fronte. Fu un attimo, si riconobbero come vecchi nemici per una questione sorta fra le rispettive famiglie e si guardarono con occhi che rivelavano sfida e desiderio di vendetta.
Intanto la madre di Vito, inquieta perché il figlio tardava a ritornare a casa, si era mossa alla volta del bosco con un triste presentimento nel cuore (il cuore di una madre non sbaglia mai) e prima ancora di arrivare sulla collina tremò nel sentire aspre parole e minacciose invettive, riconoscendo in quel tumulto di voci la voce di suo figlio.
E quale non fu il suo strazio quando vide i due giovani con il viso sconvolto, gli occhi come fiamme e i pugni tesi; il sangue grondava da varie ferite e gli abiti presentavano strappi e lacerazioni.
Invano la poveretta cercò d’interporsi facendo appello a tutto il suo amore di mamma, invano essa implorò. Era tale l’ira che annebbiava la mente dei due contendenti che essi neanche s’avvidero del pianto disperato della infelice donna. Le venne allora in soccorso la sua grande fede: si prostrò a terra e volgendo al cielo gli occhi pieni di lacrime invocò il Santo del figlio suo con tanta implorazione che San Vito accolse la sua preghiera.
Si racconta che una gran luce sfolgorò nel bosco e in mezzo ad essa apparve la splendente figura di San Vito in atto di benedire. I due giovani presi da improvviso terrore ristettero con lo sguardo pieno di meraviglia; tutta l’ira che ribolliva nel loro sangue svanì, il cuore si calmò e l’occhio diventò sereno.
Caddero in ginocchio e li prese un irresistibile desiderio di piangere. La grande luce dopo un istante svanì, ma qualche cosa della celeste apparizione rimase davanti ai due giovani e alla povera madre: una magnifica rosa fiorita per miracolo, simbolo di pace e di amore.
I due
contendenti si riconciliarono e da quel giorno, per essi indimenticabile, non
ci furono in tutto il territorio di Grana e di Casorzo amici più affezionati. E
le rispettive famiglie, riconoscenti al Santo, fecero erigere in suo onore una
Cappella. Dopo quel memorabile avvenimento la collina venne denominata San
Vito.
Fra le molte leggende di cui è ricco il nostro Paese, una, la più bella, ha per titolo “Montecapriolo”. Tutti i Granesi sanno che Montecapriolo è quella collina da cui si dominano i paesi di Cioccaro, Grazzano e Calliano, una fertile campagna coltivata a vigne, a campi e a prati.
Molti e molti anni fa essa non si presentava così, essendo tutta ammantata di boschi impenetrabili che si estendevano fino a Moncalvo. Fra quelle folte piante vivevano felici molti animali fra cui lupi, volpi, lepri, tassi e caprioli.
I cacciatori non erano numerosi come oggi e non tutti osavano avventurarsi in quelle dense boscaglie per il timore di dover lottare con i lupi. Non c’erano strade fra quella vasta distesa di alberi, ma solo sentieri, raramente percorsi dagli abitanti della zona per la presenza dei lupi stessi.
Un giorno, ormai lontano, si presentarono al parroco di Grana due fratelli contadini; erano giunti a cavallo essendo lunga la strada, o meglio il sentiero che univa la loro casa al paese, una casa rustica che sorgeva al di là del grande bosco, ed erano venuti per pregare il sacerdote di recarsi verso sera a casa loro per portare i conforti della fede al vecchio padre, gravemente ammalato.
Il parroco li assicurò e precisò che sarebbe stata sua premura raggiungere la loro abitazione all’ora stabilita.
Venne la sera e il sacerdote zelante si accinse a partire, ma siccome la strada era lunga e la notte non era lontana si servì di un cavallo di sua proprietà, un animale che lo accompagnava quando doveva compiere visite nelle case distanti dal paese.
Prese con sé quanto gli serviva per il conforto del malato, salì in sella e partì.
Già nel cielo brillavano le prime stelle e la valle si faceva sempre più scura. Camminò, camminò, con il pensiero rivolto a Dio, ma quando giunse d’innanzi al bosco e lo vide profondamente nero per le molte ombre ebbe un senso di paura e si fermò anche perché sentiva lontano l’urlo dei lupi.
Ma ecco apparire fra le piante una luce misteriosa, una luce che si avanzava. Egli, fra la meraviglia e la commozione, si chiedeva che cosa potesse significare quella luce, ma poi, fissando attentamente lo sguardo, gli parve di scorgere un animale tutto bianco ma di un bianco lucente che gli veniva incontro.
Quando gli fu vicino lo conobbe: era un capriolo dal pelo candido come la neve e dalla voce tenera come quella di un agnello, una voce che altro non era se non un saluto al sacerdote. Afferrò con i denti la cavezza che pendeva dal collo del cavallo, quindi si mosse seguendo il sentiero da cui era venuto mentre il sacerdote lo guardava con crescente stupore.
Attraversato il grande bosco, il capriolo improvvisamente sparì, ma ormai più nessun pericolo minacciava il ministro di Dio. La casa del moribondo sorgeva poco lontano e aveva le finestre illuminate. Egli entrò accolto con grande rispetto dai familiari quindi venne condotto nella camera del vecchio padre che stava agonizzando. Gli si avvicinò con parole di conforto e di speranza lo preparò al grande passo verso l’eternità.
Compiuto il commovente rito, salutò i parenti e prese commiato da quella casa. Fuori lo attendeva il fedele cavallo per il ritorno in paese. Ma quando arrivò ai margini del bosco, immerso in una profonda oscurità, avvertì nuovamente un senso di paura e non ebbe il coraggio di continuare il cammino; lontano ululavano i lupi.
Si guardò intorno ed ecco riapparve il bianco capriolo; il caro animale riafferrò con i denti la cavezza e ricondusse il sacerdote al di là del bosco, quindi sparì, così egli poté ritornare al paese in serena tranquillità.
La Domenica seguente
l’Arciprete, nel corso della messa,
parlò ai parrocchiani del misterioso incontro con il bianco capriolo, certamente
mandato da Dio, e tutti ne furono meravigliati e commossi.
In paese e nei paesi vicini si parlò a lungo dello
straordinario avvenimento e da quel giorno la bella collina venne chiamata Montecapriolo.
Il piccolo Silvano era molto ammalato.
La sua mamma, vedova, doveva affaticarsi per poter vivere la modesta vita d’ogni giorno e rendere meno triste l’infanzia del figlio suo; pallido e delicato come un fiore nato all’ombra.
Dalle prime ore del mattino all’Ave Maria della sera, ella esauriva le sue energie nei campi di un ricco proprietario. Nella dura fatica della terra, il solo conforto al suo cuore di madre era la soave visione di Silvano.
Ma, se quel visino d’angelo era la sua rosa, di quante spine era circondato quello stelo! Il bimbo cresceva, ma com’era trasparente il suo corpicino! Di grande e di sovranamente bello in quella creatura non c’era che lo sguardo: un lembo di cielo, due gemme da emanavano uno splendore di paradiso.
Una buona vicina di casa s’era offerta di custodirlo durante l’assenza della mamma e Silvano s’era abituato alla solitudine ed era pago di passare lunghe ore nel chiuso cortiletto ad accarezzare i fiori e due colombi che egli amava di un amore tenerissimo.
Ma un male segreto gli consumava le gracili membra e a nulla valevano le cure degli uomini, né il grande amore della mamma a ridargli le forze e il sorriso. L’infelice madre aveva lo strazio, ma, in presenza del figlio, tratteneva il pianto in gola e diceva parole che solo una madre sa pronunciare.
Se i miracoli della scienza e i tesori del cuore umano erano impotenti a vincere un male che non perdona, perché non ricorrere alle forze del cielo? La povera donna aveva una fede grande, una fede da muovere le montagne.
C’era là dove ora sorge la chiesetta di Sant’Antonio, una modesta Cappelletta dedicata al Santo stesso, sempre adorna di fiori. Una statuetta del grande taumaturgo sorrideva a tutti, buoni e cattivi, credenti e increduli, ma specialmente ai poveri, agli abbandonati, ai sofferenti e ai disperati.
Ogni giorno la poveretta sostava dinnanzi a quella statua a pregare come sanno pregare le mamme che hanno figli ammalati. Un giorno in cui la febbre faceva delirare il piccolo Silvano, ella, più abbattuta che mai uscì e si diresse all’altare del Santo per implorare, in uno slancio di fede, la guarigione del figlio.
D’innanzi alla soave figura di Antonio da Padova, ella pregò con fervore d’Angelo tenendo tra le mani il volto rigato di lacrime, ma come alzò gli occhi le parve che il Santo le sorridesse e che nello stesso istante una forza misteriosa la spingesse verso casa.
Si mosse, e quasi al volo raggiunse la porta della sua modesta abitazione. Chi vide entrando nella camera di Silvano? Il bambino era alzato, era interamente cambiato: il suo volto bello e fresco emanava una luce di gioia sovrumana. Uno slancio d’amore portò la madre verso il figlio ed entrambi si trovarono strettamente abbracciati.
Poi Silvano parlò: Mamma, mentre tu eri assente entrò un frate che reggeva un bel bambino e un grande giglio fiorito: dolcemente mi prese per mano e mi aiutò ad alzarmi; subito mi sentii senza febbre ed una nuova vita entrò in me. Il bambino giocò un poco con me, poi entrambi uscirono.
Il fatto straordinario si conobbe in tutto il paese e anche nei paesi vicini, e là, dove sorgeva una semplice Cappelletta, la pietà dei Granesi costruì la Chiesetta dedicata al grande Santo dei miracoli.