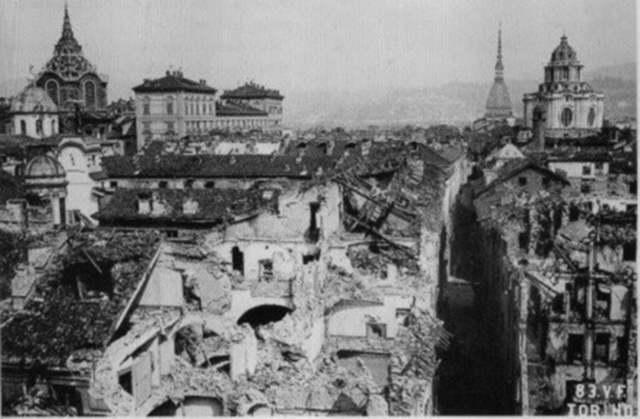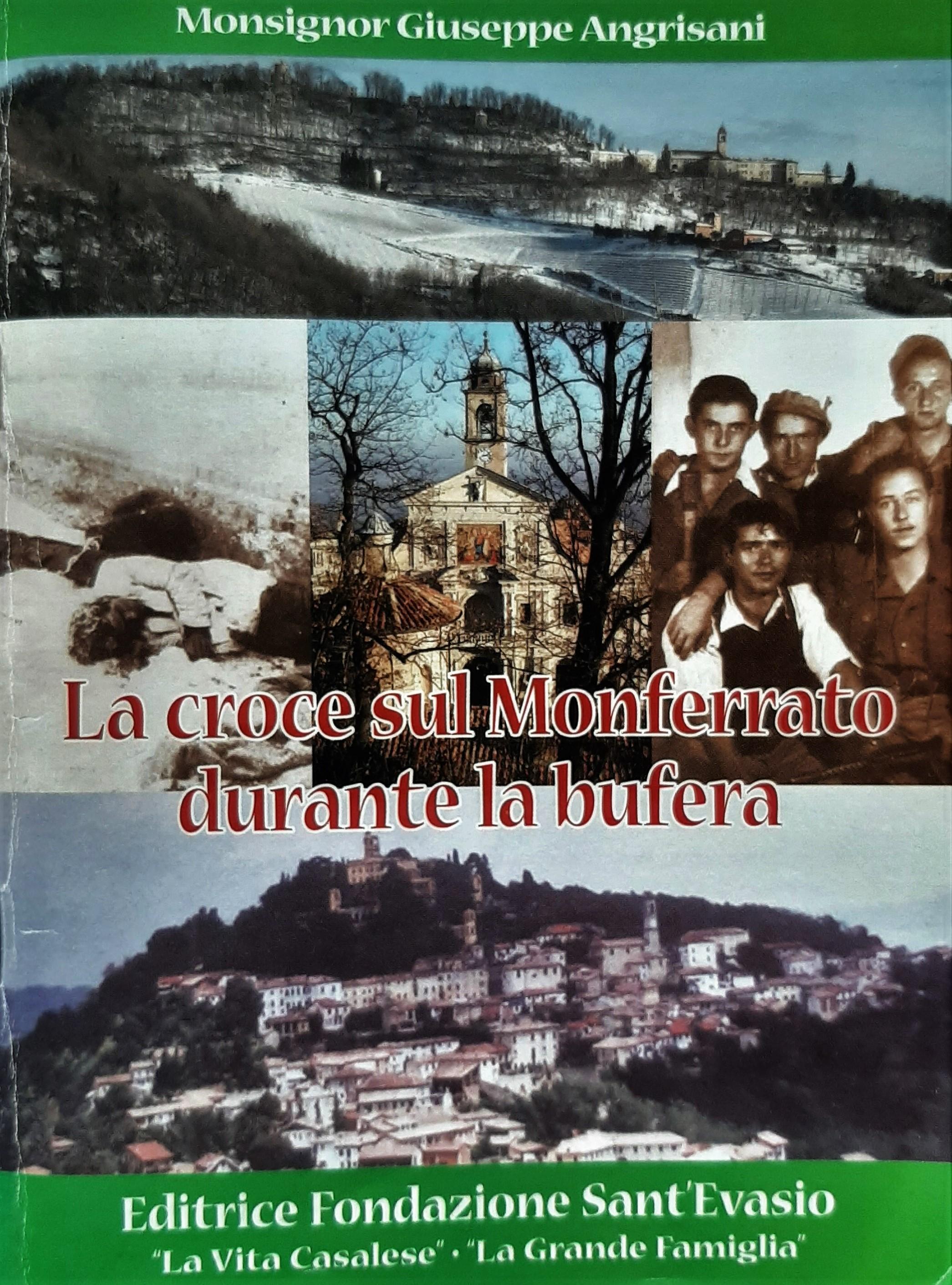Ricordi di un ex Cappellano militare 3ª parte
Il Maggiore Mayer: "siamo qui per combattere, non per trattare!"
La breve esperienza di Cappellano militare del 12° Reggimento Costiero con sede a Pietrasanta, ma dislocato in gruppi diversi nelle numerose postazioni che andavano da Monte Marcello (Bocca di Magra) a Bocca d’Arno, dalle tenute di San Rossore a quelle dei Duchi Salviati, è stata sufficiente ad abituarlo alla rudezza dell’ambiente militare e a dargli tranquillità nell’affrontare, con sufficiente disinvoltura, anche gli imprevisti più preoccupanti.
Nella seconda metà del luglio 1944 la formazione partigiana comandata da un coraggioso cittadino di Grana si trovò ad operare sulle colline di Montegrosso d’Asti. Avendo necessità di reperire un mezzo di trasporto, comandò a tre suoi concittadini che erano nel suo gruppo di scendere a valle, lungo la statale, e di requisire il primo autocarro che fosse transitato.
Per meglio riuscire nell’impresa i tre partigiani si posero all’uscita di una curva con i fucili spianati e bloccarono il primo autocarro che capitò a tiro: un veicolo tedesco con truppa sotto al telone. I tre malcapitati furono ovviamente arrestati e portati ad Asti. Il giorno seguente il capo partigiano andò in Parrocchia per chiedere che il nostro Cappellano si recasse ad Asti per avere notizie dei tre prigionieri, per sapere se erano ancora vivi o fossero stati “tradotti” in Germania, o, peggio ancora, fossero stati fucilati come stabiliva la legge.
Sulla sua fedele bicicletta il Cappellano si recò ad Asti, ma dal personale italiano del carcere non ebbe risposta, dal Comando Tedesco delle S.S. sistemato in cima alla collina, nell’edificio di proprietà delle Suore della Purificazione, venne invece a sapere che erano ancora vivi, a disposizione dell’Autorità Militare Tedesca.
La buona notizia stimolò l’inventiva del capo partigiano e dei suoi compagni, che pensarono ad uno scambio di prigionieri, pertanto si portarono presso la strada che collega Asti a Casale, sulla salita che porta a Vignale, e lì attesero. Quando spuntò da una curva un’auto con a bordo tre tedeschi, due ingegneri e l’autista diretti con dei disegni alla Way Assauto, il partigiano impose l’alt e con l’aiuto dei suoi compagni li fece prigionieri.
Questi furono nascosti in un casotto in campagna (cascinot) e ora bisognava pensare allo scambio di prigionieri, un gruppo partigiano contro la “Grande Germania”. Ma un semplice scambio sembrava troppo poco, visto che si trattava di ingegneri con dei disegni importanti, e allora perché non chiedere in cambio anche delle armi? E a chi tocco condurre la trattativa? Ovviamente al Cappellano, che in bicicletta si recò ad Asti ad incontrare il Comandante, il Maggiore Mayer.
Quel Maggiore Mayer che a Villadeati, "per un militare tedesco ucciso, applicò la terribile regola instaurata dalle S.S. e fece giustiziare 10 poveri innocenti". Ordinò la rappresaglia e dalle loro case vennero presi con la forza nove padri di famiglia ignari di tutto e giustiziati con il parroco del paese. E a questo proposito diventa veramente agghiacciante la testimonianza di Monsignor Giuseppe Angrisani, Vescovo di Casale Monferrato, che con il famigerato Colonnello Mayer ebbe al riguardo un aspro colloquio, ma soprattutto andò a Villadeati per fare visita alle famiglie dei giustiziati.
Monsignore si recò innanzi tutto a rendere omaggio alla salma di Don Ernesto Camurati, il parroco di Villadeati che aveva offerto la sua vita per avere salva quella dei nove capi famiglia che furono invece fucilati con lui. E i carnefici non ebbero pietà dell'eroico sacerdote neppure dopo la sua morte, per la quale furono necessari, oltre alla sventagliata di mitra, due colpi di pistola alla nuca. Infatti colui che lo finì disse sogghignando: "Il Pastore era duro a morire!"
Monsignore fece poi visita alle famiglie dei nove giustiziati e in quella che lui stesso definisce una Via Crucis per le case del paese viene prepotentemente alla luce l'angoscia e lo strazio che lo accompagnarono in quelle povere dimore così toccate dal dolore. Il racconto si fa crudo e descrive in modo intenso le case e lo stato d'animo suo e dei famigliari delle vittime. In una di queste il cadavere dell'ucciso sembrava occupare tutta la stanza dove era stata sistemata. La vedova piangeva in silenzio, mentre la figlia urlava il suo dolore come una belva ferita.
In un'altra trovò due bare, quelle di due fratelli falciati da iene assetate di sangue, così le definisce il prelato. La mamma è distrutta dal dolore, ma non si lamenta, solo le mani si levano a coprire il volto, in un gesto di pietà. Incontrò poi un gruppo di persone davanti ad un'altra casa dove all'interno si trovava una vedova che piangeva sulla salma del marito. Una donna si rivolge a lei e le disse: "vedi che la Provvidenza non ti ha abbandonata. Ti manda il Vescovo per dirti che è sempre con noi".
Dove però Monsignor Angrisani trova più scossa la sua sensibilità è in una casa quasi al fondo del paese. Qui intorno alla salma sono riuniti la vedova, due ragazzi e il vecchio padre con la faccia bruciata dal sole e scavata dalla fatica. Posandogli una mano sulla spalla pronuncia le parole più umili suggerite dalla fede e il vecchio padre disse: "Signore, se è necessario questo dolore perché la sua anima sia salva, sia fatta la tua volontà". A Monsignore parve un Patriarca antico, ispirato come un Profeta.
Tornando con il racconto ad Asti, il Maggiore Mayer non c’era e l’Aiutante di Campo tedesco, con molta cortesia, chiese al Cappellano di tornare il mattino dopo, cosa che avvenne puntualmente. Anche il Maggiore si dimostrò gentile e nel suo studio iniziò il colloquio. Appena saputo il motivo di quell’incontro batté violentemente un pugno sul tavolo e urlò: “noi siamo qui per combattere, non per trattare! Lei sa dov’è la città di Alba?” Alla risposta affermativa riprese: “ebbene, Alba non esiste più, sta bruciando”. E concluse: “lei adesso andrà a Grana e si farà consegnare, in giornata, i prigionieri, altrimenti verremo noi e impiccheremo in piazza i prigionieri che abbiamo e bruceremo il paese”.
Quando il Cappellano gli fece notare che era arrivato ad Asti in bicicletta e pertanto gli sarebbe servito più tempo, batté un altro pugno sul tavolo e aggiunse: “all’uscita avrà a sua disposizione una macchina della Prefettura di Asti con autista. Lei andrà a prelevare il Vescovo che è già stato preavvisato, andrete a Grana e libererete i prigionieri. E sappia che lei è responsabile della macchina, dell’autista e del Vescovo”.
Il Vescovo, già piuttosto avanti con gli anni, fece le sue rimostranze al Cappellano per l’incarico ricevuto, facendogli notare che Grana era sotto la Diocesi di Casale e pertanto l’incombenza sarebbe toccata al Vescovo di quella Diocesi, ma ovviamente queste spettanze poco interessavano ai tedeschi!
L’incontro nella Casa Parrocchiale di Grana tra il Vescovo e il capo partigiano non ebbe l’esito sperato e fu piuttosto animato. A quel punto il Prelato fu riaccompagnato ad Asti, alla sua residenza, e il Cappellano si recò al Comando Piazza a riferire al Maggiore Mayer, che non poté fare altro che rinnovare la sua minaccia e rispedire il povero “ambasciatore” a Grana. A questo proposito, riferisce il Cappellano che l’autista era piuttosto preoccupato, temendo di essere fatto a sua volta prigioniero.
C’è una nota curiosa su questo viaggio di ritorno: all’uscita di Asti incontrarono un partigiano, armato di pistola e noto al Cappellano, che chiese un passaggio fino a Grana ed ecco che sulla macchina della Prefettura troviamo un militare tedesco preoccupato, uno spavaldo partigiano e un prete che si stava arrovellando per trovare una soluzione alla difficile situazione.
In cima alla salita di Calliano, al bivio per Moncalvo o Grana, spuntarono due autovetture dirette ad Asti. Il partigiano ordinò all’autista di fermarsi, scese per breve tempo a terra e poi fece cenno di proseguire. A quel punto l’autista fece notare al Cappellano un particolare che gli era sfuggito: le due auto erano state sequestrate e li stavano seguendo. Quest’ultimo non esitò neppure un attimo e obbligò il partigiano a lasciare libere le due auto e i loro occupanti, che a loro volta dimostrarono enorme soddisfazione.
Giunti a Grana il partigiano andò in cerca del capo e l’autista fu invitato a invertire velocemente la marcia e tornare ad Asti, onde evitare possibili ritorsioni. Nel salire a piedi verso la Chiesa, il Cappellano chiese a chi incontrava di mandare più uomini possibili nella Casa Parrocchiale, in quanto un grave pericolo incombeva sul paese. Il suo appello fu ascoltato e in breve si radunò un numero imponente di capifamiglia, tanto che il capo partigiano, al suo arrivo ne restò impressionato.
Saputa la minaccia del Colonnello Mayer gli uomini di Grana supplicarono il capo partigiano di usare prudenza, in quanto ne andava della vita dei loro figli e della salvezza delle loro case. A malincuore il capo si convinse a consegnare i prigionieri, senza contropartita, trattenendo però le armi sequestrate. Gli uomini restarono tutti in Canonica fino alla liberazione dei prigionieri e dal posto pubblico fu telefonato al Maggiore: “la popolazione di Grana ha liberato i prigionieri, venite a prenderli!”
La spedizione tedesca fu attesa da Cappellano e Sindaco all’inizio del paese e all’imbrunire giunsero la macchina con gli Ufficiali e due autoblindo con un gruppo di militari. Dopo i convenevoli si recarono tutti in Canonica e ai prigionieri tedeschi fu chiesto se avessero subito dei maltrattamenti. Fortunatamente la risposta fu negativa, ma la situazione si complicò quando il Maggiore Mayer seppe che le armi non erano state riconsegnate.
Come sua abitudine dette un violento pugno sul tavolo e rinnovò la minaccia di impiccare e incendiare, ma il Cappellano fu abile nel fargli notare che i prigionieri erano stati liberati e il capo partigiano era fuggito portando con sé le armi e nessuno sapeva dove fosse andato. L’ira del Maggiore si placò e addirittura lodò la popolazione, scagionandola da ogni responsabilità e solo il comandante dei partigiani era responsabile della restituzione delle armi, pena la morte. Ma tanto di condanne a morte ne aveva accumulato già molte altre, pertanto una più o una meno…
Intanto il pericolo era scampato e la gente di Grana poté respirare un po’ più liberamente.